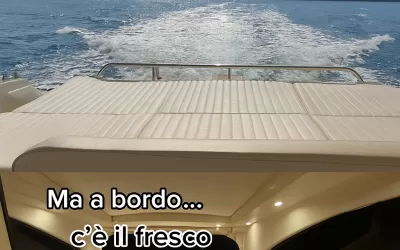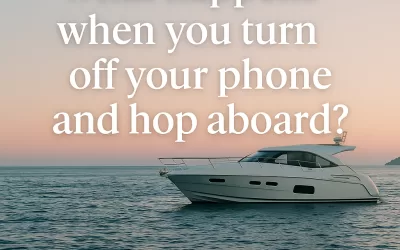Pronti per un tour guidato tra miti e leggende della riviera ligure? Sì, perché è stata teatro di tante leggende tramandate ancora oggi, che attraverso le peripezie di divinità e creature marine narrano la nascita dei più bei borghi di mare della nostra regione.
Sestri Levante

La splendida cittadina sul Golfo del Tigullio è soprannominata “città dei due mari” per la sua particolare geografia: l’antico centro storico si poggia su un isolotto collegato alla terraferma da un istmo tra due baie, quella delle Favole e quella del Silenzio. Questa sottile striscia di terra che collega le due baie è la protagonista del mito che narra dell’origine di Sestri Levante.
L’amore tra Segesta e Tigullio
Segesta era il nome di una delle sette figlie di Nettuno, il re dei Sette Mari: quell’isola bellissima e incontaminata del Mar Ligure che conosciamo molto bene è dedicata a lei. Si narra che Nettuno si rivolse a sirene, nereidi e ondine per proteggere l’isola dalla minaccia di pirati e pescatori. Mentre le ninfe si stagliavano sugli scogli a fare da guardia alla perla del mare, i tritoni non potevano salire in superficie. Erano così costretti a rimanere sul fondale per non disturbarle.
Un giorno il tritone Tigullio, sentendo l’ammaliante canto delle sirene, decise di non obbedire all’ordine di Nettuno. Vedendo Segesta cantare e specchiarsi nelle acque del mare, non poté che innamorarsene. Tigullio allungò un braccio per toccare la coda della sirena, e fu per entrambi un classico colpo di fulmine. Nettuno non tardò a scoprirli e a scatenare la sua ira, pietrificando il braccio di Tigullio e la coda di Segesta, che così uniti andarono a formare un istmo collegato alla terraferma: Segesta Tigullorum, quella che oggi conosciamo come Sestri Levante. Da allora Nettuno, impressionato e un po’ pentito per la sua stessa furia che causò la trasformazione della figlia prediletta, lasciò i tritoni liberi di nuotare in superficie insieme alle sirene.
L’eredità della serena e del tritone
Questa vicenda a dir poco romanzesca potrebbe aver ispirato Hans Christian Andersen. Lo scrittore danese, di passaggio a Sestri Levante nel 1833, prese spunto da questa leggenda per una delle sue fiabe più note, La Sirenetta, pubblicata nel 1837. Per ricordare il passaggio dello scrittore il presentatore genovese Enzo Tortora, durante una puntata del mitico programma tv “Campanile Sera” registrata a Sestri Levante, coniò il nome di “Baia delle Favole“. Ma come dicono i grandi narratori, questa è un’altra storia.
San Fruttuoso

Eccola qui, forse la leggenda ligure più famosa. Santi, angeli e draghi, i suoi protagonisti.
La storia è questa: tantissimi anni fa la stupenda baia dove oggi troviamo l’abbazia di San Fruttuoso fu scelta come nuova casa da un drago molto temibile. Così spaventoso e feroce da uccidere e divorare chiunque provasse a transitare per quei luoghi incantati. Le barche ovviamente iniziarono a tenersi alla larga dalla baia, che divenne sempre più isolata.
Un giorno, poco dopo la morte di San Fruttuoso, un angelo fede la sua comparsa davanti a Giustino e Procopio, ex seguaci del martire. Disse loro che li avrebbe condotti in un luogo speciale, per costruire una chiesa in memoria del santo. Ed è qui che si sono imbattuti nel drago, che dopo una sanguinosa battaglia con l’angelo fu finalmente sconfitto, nonostante gli enormi cavalloni d’acqua scagliati verso gli eroi.
Così nacque la chiesa di San Fruttuoso, divenuta oggi una magnifica Abbazia conosciuta in tutto il mondo. Come spesso succede, questi miti possono avere diverse versioni. Una di queste dice che fu San Fruttuoso in persona a comparire in sogno ai suoi compagni, dicendo loro di cercare un luogo riconoscibile per tre segni: un drago, una fonte d’acqua e una caverna, che in effetti (tolto il drago) sono elementi che troviamo nella baia ancora oggi.
Ma come era possibile che tutti gli abitanti di San Fruttuoso, all’epoca, erano convinti dell’esistenza e della presenza del drago? Colpa dei marinai, che si erano inventati questa storia per tenere le altre navi a distanza dalla fonte d’acqua presente nella baia.
Il tesoro del pirata nella grotta di Paraggi
Il Castello di Paraggi, eretto dalla Repubblica di Genova per stabilire una presenza sulle coste del Golfo del Tigullio, si staglia sulla piccola frazione omonima nei pressi di Santa Margherita Ligure, che come sappiamo oggi è una importantissima meta turistica. Il castello sorge su un promontorio a picco sul mare, su cui si apre una splendida grotta che secondo la leggenda era abitata da un mostro tremendo, lì per fare da guardia a un ricchissimo tesoro, nascosto lì dopo un tremendo naufragio dei pirati che lo avevano trovato. Gli ultimi sopravvissuti si rifugiarono nella caverna, esalando i loro ultimi respiri circondati dalle ricchezze portate in salvo. L’ultimo atto del capitano di quel veliero fu di trasformarsi in una mostruosa ed enorme murena, che avrebbe dovuto proteggere per sempre il frutto delle loro scorribande.
Il demone nero di Moneglia
 Nel 1396 i frati francescani di Moneglia ebbero l’onore e l’onere di erigere una chiesa a San Giorgio. Questo grazie al lascito di Monna Benvenuta, moglie del ricco mercante Leonardo di Solarolo. Nel tempo, i frati arricchirono la chiesa acquistando e commissionando numerose opere tra cui un polittico dedicato a San Ludovico da Tolosa, dipinto dal pittore genovese Giovanni Barbagelata nel 1503, che raffigurava ai lati anche i santissimi Ambrogio, Stefano, Nicola e Antonio Abate.
Nel 1396 i frati francescani di Moneglia ebbero l’onore e l’onere di erigere una chiesa a San Giorgio. Questo grazie al lascito di Monna Benvenuta, moglie del ricco mercante Leonardo di Solarolo. Nel tempo, i frati arricchirono la chiesa acquistando e commissionando numerose opere tra cui un polittico dedicato a San Ludovico da Tolosa, dipinto dal pittore genovese Giovanni Barbagelata nel 1503, che raffigurava ai lati anche i santissimi Ambrogio, Stefano, Nicola e Antonio Abate.
Prima dell’alba del 7 gennaio 1550 però, la pala d’altare non sfoggiava la bestia nera che oggi appare ai piedi di Sant’Antonio. Com’è possibile?
Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio un bufera imperversava su Moneglia: i vento fracassava i rami degli alberi, il mare in burrasca scuoteva le barche alla fonda. Un fulmine squassò il tetto della chiesa di San Giorgio e la tempesta strappò via la croce del campanile. Quando il lampo della folgore si spense, un ghignante demone nero sedeva al posto della croce. In quella notte il demone imperversò tra i vicoli del borgo seminando terrore e distruzione, costringendo gli abitanti a munirsi di amuleti, forconi, torce e armi con cui eliminare la minaccia.
Il demonio tentò un’ultima fuga e si tramutò in una bestia nera, rifugiandosi all’interno della chiesa ai piedi di Sant’Antonio abate, protettore degli animali. Ma non ebbe la fortuna sperata, perché il santo lo riconobbe e lo immobilizzò con il suo bastone. Ancora oggi, quel demonio trasfigurato giace là, terrorizzato.
La processione dei morti a Portofino
La morale di questa storia è molto semplice: la notte del 31 ottobre, meglio non recarsi alla chiesa di San Giorgio. Sorge su una scogliera a picco sul mare, in uno dei punti più panoramici di Portofino edificata su una antica cappella votiva a pianta quadrata, su richiesta dei pescatori di corallo del XIX secolo.
Questa macabra leggenda racconta che intorno a mezzanotte, dal fondo alla scogliera, inizia una spaventosa processione dei morti affogati, che risale lungo le rocce ed entra in chiesa. I fantasmi, o zombie, chiamateli come volete, dopo essersi inginocchiati in silenzio davanti all’altare, si incamminano in direzione del balcone naturale, tristemente noto per scatenare istinti suicidi, e si gettano nelle fredde e buie acque del Mar Ligure.
Portovenere

Un’antica leggenda narra di Martina, una ragazza che viveva con suo padre e suo fratello a Ria, un paese poco prima di Portovenere che ha poi preso nome di Le Grazie. Martina, ogni giorno, attendeva la propria famiglia di pescatori al porto, per aiutare a scaricare la barca dal pescato destinato alla vendita sul porticciolo.
Un giorno attraccò al porticciolo un veliero genovese in avaria, e tra i numerosi marinai scesi dall’imbarcazione c’era un ragazzo giovane e bello, Almicare: tra lui e Martina era scattato il classico colpo di fulmine. I due, dopo molti giorni passati insieme a fantasticare su un futuro insieme, furono bruscamente interrotti. La nave era stata rimessa in sesto, tutti i marinai furono richiamati a bordo e Martina, recatosi al porticciolo come ogni giorno, non riuscì a stare inerme a guardare il proprio amore allontanarsi, così iniziò a correre fino a Portovenere. Di lei non si ebbero più notizie. La leggenda popolare narra che il suo fantasma sia ancora lì ad aspettare Almicare, che però non tornò mai più. Oggi il nome di Martina è inciso sulla targa di un vicolo del paese, e non solo, perché La Martina è il nome di una località tra Portovenere e le Cinque Terre.
La Venere
Un’altra curiosità, più che una leggenda, che sicuramente stuzzicherà gli appassionati d’arte: a Porto Venere, per esattezza nella frazione di Fezzano, nacque Simonetta Vespucci, la modella a cui Sandro Botticelli si ispirò per la celebre opera della Nascita di Venere: era infatti ritenuta dai suoi contemporanei la più bella donna vivente dell’epoca (siamo in pieno Quattrocento).
Perchè “Cinque Terre”?
Il nome delle “cinque terre” è dato ai borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. In passato, erano quasi completamente isolati dall’entroterra ed era possibile raggiungerli quasi esclusivamente attraverso il Mar Ligure o percorrendo sentieri non agilissimi, ma con panorami stupendi a picco sul mare. Il nome sta quindi a sottolineare il fatto che esse rappresentino terre, nell’accezione di “territori” lontani e fuori dal mondo, cosa che ne giustifica una volta di più l’inserimento nel novero dei patrimoni dell’umanità
Camogli

A poca distanza dal capoluogo ligure, c’è lo spettacolo delle case colorate di Camogli. L’arcobaleno di pareti non nasce per fare da sfondo alle foto dei turisti più attenti ai loro profili social, bensì è dovuto al suo passato da borgo marinaro: i colori accesi permettevano ai marinati di rientro dalla battuta di pesca di riconoscere più facilmente le proprie abitazioni, dove ad aspettarli trovavano le amate mogli; da qui il nome della località che in dialetto, Camoggi, ovvero “casa delle mogli”.
La scelta di colori così vivaci deriva dal fatto che per dipingere le case venivano utilizzati i residui di colore rimanenti dalla pitturazione delle barche. Tali colori avevano più di un vantaggio: in primis la materia prima, che essendo residuale dai lavori di cantiere, era già pagata dagli armatori; e poi la qualità della tinta, che essendo fatta per reggere le intemperie marine, era ottima.